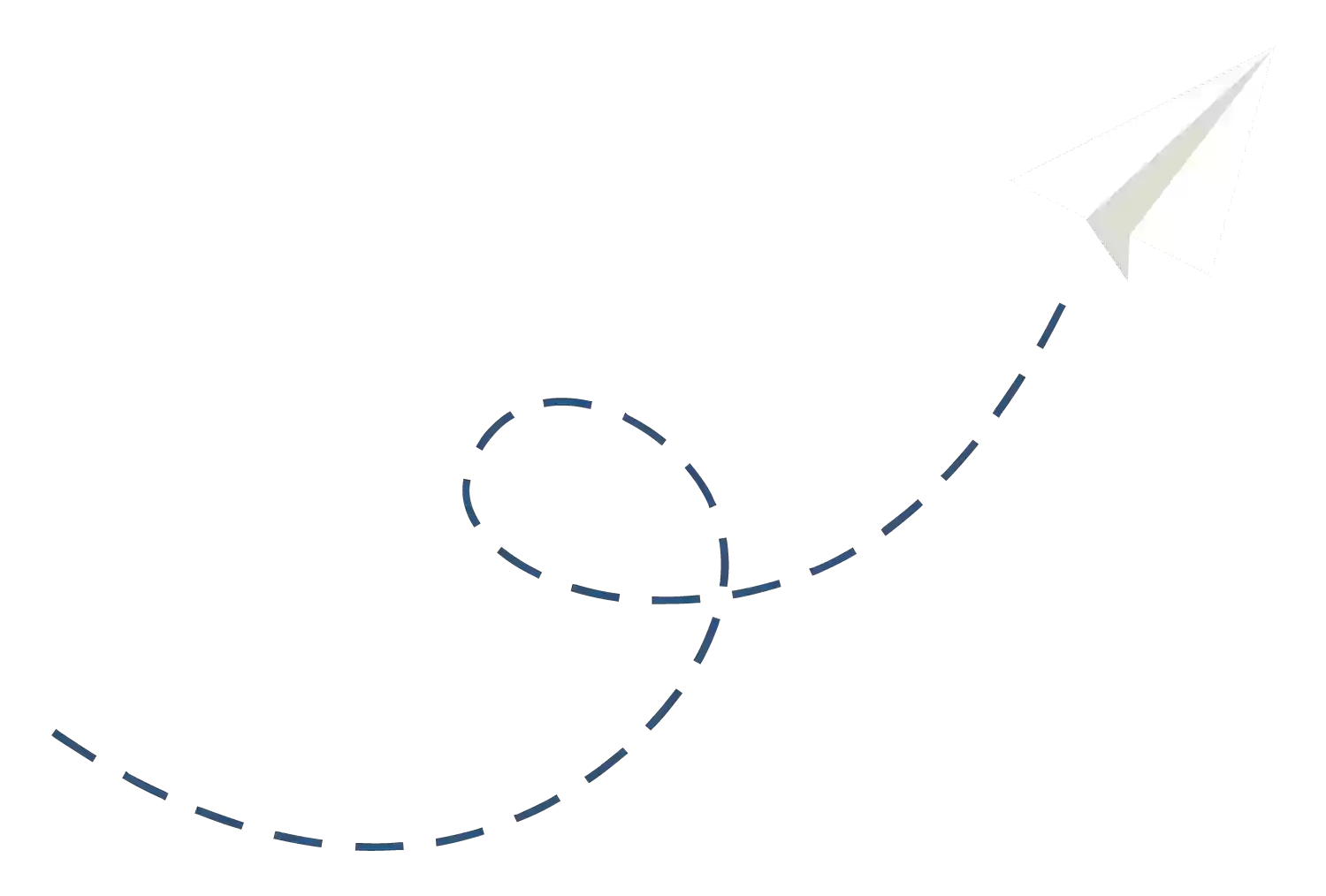Il licenziamento nelle piccole imprese tra legislatore e Corte costituzionale
| di Mariella Magnani
Bollettino ADAPT 14 luglio 2025, n. 27
1. Cerco di essere didascalica a beneficio dei molti che, sebbene siano addetti ai lavori, possono aver perso la contezza dell’attuale disciplina dei rimedi al licenziamento illegittimo dopo gli innumerevoli interventi della Corte costituzionale.
Tra l’altro, ricostruire il quadro attuale della disciplina dei licenziamenti è indispensabile per valutare la nuova questione di legittimità costituzionale dell’art. 9 del d.lgvo. n. 23 del 2015 prospettata alla Corte (cfr. Trib. Livorno, 29 novembre 2024) e della cui pronuncia si è in attesa.
Dunque quale è questo quadro? Resta la duplicità di regime tra i lavoratori assunti prima e quelli assunti dal 7 marzo 2015. Si tratta di una duplicità di regime avallata dalla Corte costituzionale già con la sentenza n. 194/2018, con l’osservazione che “l’introduzione di tutele certe e più attenuate in caso di licenziamento illegittimo è diretta ad incentivare le assunzioni a tempo indeterminato e quindi appare coerente limitare l’applicazione delle stesse tutele ai soli lavoratori assunti dalla loro entrata in vigore, quelli, cioè, la cui assunzione avrebbe potuto essere favorita”.
Senonché, successivamente, con una serie di pronunce prima sul d.lgvo n. 23 del 2015, poi sulla cd. legge Fornero, poi di nuovo sul Jobs Act, almeno quanto alla scelta tra regime reintegratorio e regime indennitario, essa ha finito per avvicinare se non uniformare la disciplina del Jobs Act a quella della legge Fornero. Questo per dire che, per mano della stessa Corte costituzionale, il quadro regolamentare in cui si colloca il monito di Corte cost. n. 183/2022 – monito che, non dobbiamo dimenticarlo, riguardava la necessità di una revisione in termini complessivi dell’intera disciplina rimediale dei licenziamenti – è profondamente mutato.
E di ciò non si può non tenere conto nell’analizzare il regime del licenziamento nelle “piccole imprese”, vale a dire i soggetti destinatari del regime di cui all’art. 9, co. 1, d.lgvo n. 23 del 2015, e non potrà non tenerne conto la stessa Corte costituzionale, per fare in modo che tutto si tenga, salvaguardando la coerenza dell’ordinamento.
2. Nel nuovo quadro, il regime dei rimedi al licenziamento illegittimo nella piccola impresa resta divaricato: per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 resta la l. n. 604 del 1966, con la reintegrazione prevista solo nel caso di licenziamento discriminatorio o nullo o comunicato in forma orale, per cui si applica la tutela reintegratoria cd. piena ex art. 18, co. 1, 2 e 3; mentre nel caso di licenziamento ingiustificato vi sarà l’alternativa, a scelta del datore di lavoro, tra la riassunzione e l’indennità risarcitoria tra 2,5 e 6 mensilità della retribuzione, maggiorabile sino a 10 mesi per i lavoratori con anzianità superiore a 10 anni e a 14 per i lavoratori con anzianità superiore a 20 anni, se il datore di lavoro occupa più di 15 prestatori di lavoro (requisiti cumulativi: cfr. Cass. 22 maggio 2025, n. 13741). Poi, a seguito di una giurisprudenza creativa, si è applicato il regime previsto per il licenziamento ingiustificato anche nel caso di vizio procedurale; e successivamente pure nel caso di vizio formale (mancata comunicazione dei motivi), nonostante che in questo caso la legge faccia riferimento all’inefficacia (dunque nullità di diritto comune) (cfr., di recente, Cass. 15 giugno 2022, n. 19323; Cass. 20 marzo 2019, n. 7851; Cass. 5 settembre 2016, n. 17589).
Invece, nel regime del Jobs Act, per le imprese minori in caso di ingiustificatezza del licenziamento (ovvero di vizio procedurale e formale, qui accomunati dal punto di vista del tipo di sanzione) si applica una tutela meramente indennitaria, che oggi, a seguito del d.l. 87 del 2018, varia da un minimo di tre ad un massimo di sei mensilità; mentre in caso di licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale si applica il regime reintegratorio.
3. È chiaro che vi sono differenze tra i due regimi, ante e post Jobs Act, ma l’esistenza di queste differenze è stata avallata dalla Corte Costituzionale; così come, d’altro canto, facendo riferimento specificamente alla piccola impresa, non vi è dubbio che il legislatore potrebbe ricondurle ad unità, tanto più che il “glorioso” regime della legge n. 604 del 1966, già prevalentemente indennitario, ha resistito alla prova del tempo e dei giudizi di costituzionalità.
4. Ci si è già ampiamente domandati che cosa potrà fare la Corte costituzionale di fronte alla riproposizione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 9 del d.lgvo n. 23 del 2015.
Veramente l’intervallo tra 3 e 6 mensilità nel massimo può essere considerato costituzionalmente illegittimo? E sulla base di quale norma? Tanto più, preme ricordarlo, che nella nuova ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale la questione del limite massimo dell’indennità è strettamente collegata al problema dei criteri per determinare che cosa è piccola impresa.
Osserva il Tribunale di Livorno che il Jobs Act fa dipendere il limite massimo dei 6 mesi da un elemento estraneo al rapporto di lavoro: “il limite dimensionale costituito dal numero degli occupati che, nell’attuale contesto socio-economico, risulta anacronistico e non capace di rispecchiare di per sé la concreta forza economica del datore di lavoro”.
Quindi, nella prospettazione del giudice rimettente, non è in sé il limite massimo ad essere contestabile, quanto il fatto che esso si applica indistintamente anche ad imprese che, pur avendo un contenuto numero di dipendenti, hanno grandi potenzialità economiche.
Eppure si è tutti d’accordo nel dire che, se c’è un punto in cui appare problematica una sentenza additiva, integrativa o ricostruttiva della Corte costituzionale (cfr., ad es., C. Zoli, Il regime dei licenziamenti nelle piccole imprese: una questione aperta, in DRI, 2025, 569 ss.), è proprio quello della definizione dei criteri per misurare la potenzialità economica dell’impresa e che giustificherebbero trattamenti differenziati sul piano del regime del licenziamento.
E ciò quando, come ho già notato, il sospetto di illegittimità della limitazione dell’indennità (nel massimo di 6 mesi) è, da parte del giudice rimettente, legata proprio a questo problema, insolubile, mi pare, dalla Corte.
5. Tutto questo per dire che non ritengo che la Corte costituzionale (al di là di chi ha prefigurato, radicalmente, la possibilità di una pronuncia di inammissibilità per ragioni processuali, vale a dire l’irrilevanza nel giudizio a quo, avendo la ricorrente richiesto la condanna alla reintegrazione: cfr. C. Pisani, Il licenziamento nelle piccole imprese: dal “supermonito” di Corte cost. n. 183/2022 alla nuova rimessione del Tribunale di Livorno, in LG, 2025, 82 ss.) possa molto; e che la via maestra appare quella legislativa, attraverso la quale anche le categorie produttive potranno dire la loro e, se anche si rimanesse ancorati, per fissare la soglia, al numero dei dipendenti, potrebbero essere ipotizzate graduazioni intermedie (ad es. tra i 10 e i 15 dipendenti o altre ancora). Ma si tratterebbe appunto di graduazioni fissate legislativamente e non lasciate alla consueta discrezionalità del singolo giudice.
6. Come ho avuto occasione di rilevare in un commento a un progetto di riforma (legislativa) di origine dottrinale (cfr. M. Magnani, Ancora sulla disciplina dei licenziamenti: prime riflessioni sulla proposta di riforma del gruppo Freccia Rossa, in Boll. Adapt 17 marzo 2015) la strada è sostanzialmente segnata (e collaudata) sia sul piano del quantum dell’indennizzo sia sul piano dei livelli da cui far partire la tutela differenziata. Ed è segnata dalla l. n. 604 del 1966 (che, come ricordato, prevede un range da 2,5 fino a 6 mensilità di retribuzione, maggiorabili sino a 10 per i lavoratori con anzianità superiore a 10 anni e sino a 14 per lavoratori con più di 20 anni di anzianità ed impiegati in imprese occupanti più di 15 dipendenti, con i relativi criteri di calcolo). Modello che non mi pare sia mai stato oggetto di censure da parte della Corte costituzionale.
Sul tema complesso dei criteri per l’individuazione delle soglie – per la verità oggetto di un dibattito assai risalente perché non è da oggi che assistiamo ad un’evoluzione tecnologica ed organizzativa delle imprese – molte sono le controindicazioni dei criteri che si discostano dal numero degli occupati. E, prima di imbarcarsi in nuove avventure, bisognerebbe almeno confrontarsi con le indicazioni che vengono dal diritto comparato (ovviamente sempre, quando si tratta di comparazione, con gli opportuni caveat: in sintesi, la comparazione deve essere funzionale e non strutturale).
Mariella Magnani
Professoressa emerita di Diritto del lavoro dell’Università di Pavia
Condividi su: