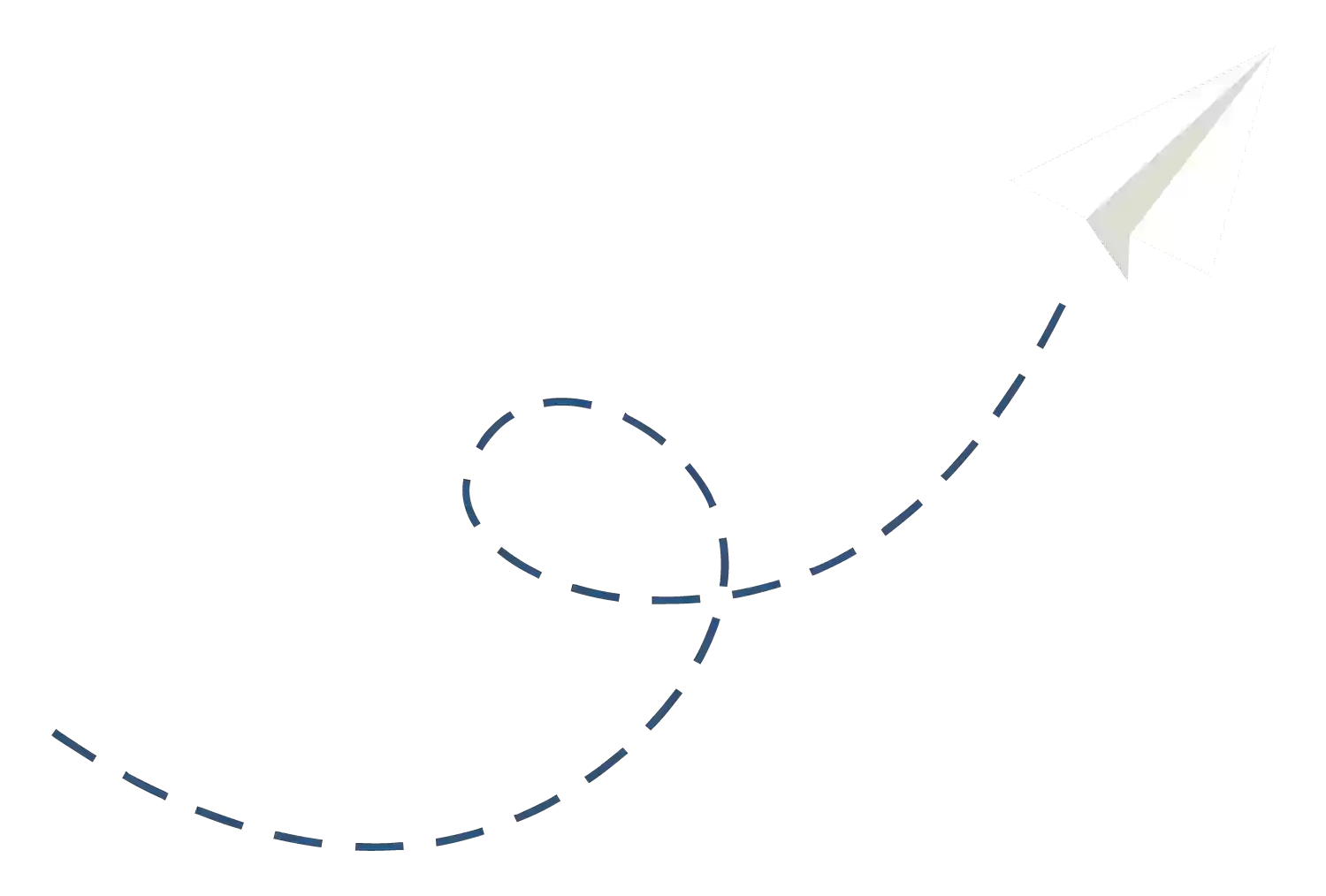Qualche domanda sul personale – ADAPT incontra Massimo Bottacin, Chief People Officer di Bauli
| di Arianna Zanoni
Bollettino ADAPT 14 luglio 2025, n. 27
Nell’ambito della rubrica Qualche domanda sul “Personale” abbiamo intervistato Massimo Bottacin, dal
2021 Chief People Officer e membro del Management Team in Bauli, con una laurea in giurisprudenza all’ Università di Ferrara e una carriera di oltre 20 anni in ambito HR, per porgli alcune domande relative alla gestione delle risorse umane in azienda.
Ci parli di Bauli
Bauli è un’azienda con 103 anni di storia, nata come impresa a conduzione familiare e oggi leader in Italia nella produzione di dolci da ricorrenza, con marchi iconici come Bauli, Motta, Bistefani e Alemagna. Negli anni, ha ampliato la propria offerta anche nel segmento dei prodotti da consumo quotidiano, in particolare nelle merende “all’italiana”, ma anche nei biscotti e nel salato.
Per molti decenni l’azienda ha seguito un percorso di crescita interna. La svolta è arrivata nei primi anni 2000, con una strategia di espansione inorganica che ha portato all’acquisizione di realtà come Doria, Motta e Bistefani, aprendo così l’ingresso in nuove categorie di prodotto e ampliando il perimetro del business. Oggi Bauli è un gruppo da circa 650 milioni di euro di fatturato e conta 1.350 dipendenti stabili, che salgono a circa 2.200 nei periodi di picco stagionale, come il Natale. L’azienda ha saputo trasformarsi nel tempo: da impresa a conduzione famigliare è diventata una realtà famigliare ma a conduzione manageriale, grazie anche alla visione lungimirante della proprietà, che negli ultimi vent’anni ha progressivamente affidato al management la gestione operativa dell’organizzazione. L’85% del fatturato proviene ancora dal mercato italiano, ma l’internazionalizzazione è uno dei pilastri strategici su cui l’azienda sta puntando con sempre maggiore convinzione.
Da oltre due anni e mezzo Bauli è impegnata in un importante percorso di evoluzione e trasformazione, che coinvolge non solo le strategie di business, ma l’intera cultura aziendale. Come afferma il nostro Amministratore Delegato, Fabio Di Gianmarco, infatti “non può esserci una trasformazione del business senza prima un cambiamento culturale profondo.”
Ritiene che i modelli partecipativi di cui si discute molto possano effettivamente essere di supporto all’innovazione organizzativa? Quale dovrebbe essere il ruolo del sindacato in questo contesto?
Dopo 25 anni di esperienza professionale, iniziata in Electrolux – realtà pioniera nei modelli partecipativi– posso affermare di aver toccato con mano le potenzialità di questi approcci nell’ambito delle relazioni industriali. La partecipazione, se ben impostata, può certamente contribuire all’innovazione organizzativa, ma richiede uno sforzo bilaterale: da un lato l’azienda deve investire tempo, risorse e competenze specifiche, dall’altro il sindacato deve essere pronto a un confronto maturo, concreto, e non ideologico. Tuttavia, oggi vedo una difficoltà crescente: i modelli partecipativi di 25 anni fa erano più agibili in un contesto dove esisteva una cultura forte della rappresentanza sindacale, cultura che oggi si fa sempre più faticosa da ritrovare. La partecipazione non può essere solo una responsabilità dell’impresa, serve una pari capacità di confronto e una visione strategica anche da parte sindacale, che non si deve ingaggiare solo in “battaglie di posizione” o solo su interessi particolari.
Quello che mi preoccupa, soprattutto di fronte a recenti innovazioni legislative in materia, è la carenza di un solido sostrato culturale che consenta di cogliere appieno la portata – e la complessità – di scelte così avanzate. C’è il rischio che le parti si concentrino solo su alcuni vantaggi immediati del modello, perdendo di vista l’approccio sistemico che invece è necessario. Serve una visione olistica, concreta e realistica. La partecipazione non può essere vista solo come uno strumento per ridurre il conflitto né può limitarsi a logiche meramente economiche: se così fosse, non riusciremmo a cogliere le vere sfide organizzative e sociali. Nel mio attuale contesto, quello del Gruppo Bauli, abbiamo cercato di costruire un modello di relazioni industriali pragmatico, rispettoso delle diverse eredità culturali delle aziende acquisite (come Motta, con una storia complessa tra proprietà private e pubbliche, o Doria, più piccola e con un’impronta imprenditoriale distinta). Abbiamo cercato di valorizzare queste storie con il sindacato, avviando percorsi di integrazione e contaminazione di buone pratiche partecipative, dandoci il tempo perché la cultura di Bauli potesse venire appieno diffusa e non vissuta come conflittuale con quelle ereditate dalle aziende acquisite.
Non siamo ancora davanti a un modello partecipativo nel senso più alto e compiuto del termine, ma credo che i passi compiuti vadano nella direzione giusta, dimostrando che partecipazione e innovazione possono rafforzarsi reciprocamente – a patto che esista la volontà, da entrambe le parti, di confrontarsi davvero.
Nella vostra realtà applicate un contratto aziendale? In caso affermativo quali sono gli elementi più rilevanti?
Oggi abbiamo 4 contratti aziendali e in tutti i siti un sistema di relazioni sindacali aperto, orientato al dialogo. Il sindacato, in questo contesto, ha colto l’opportunità di farsi portatore di modelli di sviluppo e innovazione. Un esempio concreto è stato il rinnovo del contratto integrativo dell’ex Doria, dove abbiamo introdotto strumenti innovativi come la struttura dei permessi solidali. Anche nella costruzione dei premi di risultato, abbiamo inserito nuovi KPI legati a temi quali la riduzione degli scarti e la sicurezza sul lavoro, trovando sempre un interlocutore sindacale disponibile al confronto e capace di accettare la sfida del cambiamento.
I contratti aziendali che abbiamo costruito sono fortemente legati alle specificità del settore e si fondano su alcuni elementi cardine che riteniamo imprescindibili. Uno di questi è la qualità del prodotto, che a sua volta dipende dalla qualità del processo. Per questo, valorizziamo con grande attenzione tutte le pratiche che puntano a ridurre lo scarto, una scelta che ha ricadute importanti sia in termini di sostenibilità economica sia di sostenibilità ambientale. In un momento storico segnato dalla crescente scarsità delle risorse, ridurre lo spreco alimentare rappresenta una responsabilità etica e strategica.
Un altro ambito centrale è quello della sicurezza sul lavoro, su cui vi è una sensibilità condivisa da entrambe le parti, azienda e sindacato. Riteniamo che il primo dovere, per tutti, sia quello di garantire un ambiente di lavoro sicuro, promuovendo comportamenti responsabili che tutelino sé stessi e i colleghi. A livello normativo, abbiamo quindi introdotto pratiche costanti di consultazione e valorizzato il ruolo degli RLS (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza). Alcuni KPI legati alla sicurezza e alla qualità – inizialmente considerati solo in ambito di monitoraggio – sono stati concordemente portati nella parte economica dei contratti, collegandoli ai premi di risultato.
Lo strumento del welfare aziendale viene spesso inteso come una mera erogazione monetaria nonostante possa rappresentare un valido strumento di accompagnamento delle trasformazioni in corso nelle imprese e nel mercato del lavoro. Come intende lei questo strumento?
Per quanto riguarda il cosiddetto “welfare”, preferiamo parlare di benessere aziendale in un’ottica più ampia e integrata. Abbiamo scelto di investire su strumenti concreti e condivisi con il sindacato, come permessi solidali, estesi a tutti i contratti integrativi; permessi aggiuntivi per la cura di familiari anziani; ampliamento dei congedi parentali per malattia dei figli; attività di “caring” costruite su esigenze reali emerse dal confronto con la rappresentanza dei lavoratori.
Quella che inizialmente era una logica legata alla premialità si è trasformata in una vera e propria scelta di campo. Oggi riteniamo che sostenere i bisogni di vita delle persone sia parte integrante della responsabilità sociale dell’impresa. Per questo, molti strumenti di welfare sono stati “sganciati” dal risultato economico e sono stati resi strutturali, in aggiunta alla retribuzione ordinaria.
Parallelamente, abbiamo mantenuto la convertibilità del premio di risultato in credito welfare, gestito tramite una piattaforma online a cui i dipendenti possono accedere anche via email personale. L’adesione a questo strumento è altissima: i tassi di utilizzo dei crediti welfare superano il 98%, segno che si è radicata una cultura che valorizza il welfare tanto quanto la retribuzione monetaria. Sarebbe auspicabile, da parte della politica nazionale, un maggiore sostegno legislativo. In questi anni, l’aumento dei limiti di fringe benefit e la detassazione dei premi di risultato sono stati passi positivi, ma anche contraddittori rispetto all’aspirazione a favorire strumenti strutturati di welfare aziendale, tanto che il potenziale è ancora inespresso. Lo strumento del welfare potrebbe diventare ancora più potente se si ampliasse il paniere di servizi agevolabili, e se si rafforzassero gli incentivi fiscali. Ciò permetterebbe alle aziende di svolgere un ruolo attivo nel sostenere bisogni primari dei cittadini – come l’accesso alle cure mediche o l’assistenza agli anziani – contribuendo concretamente a colmare il gap lasciato dal sistema pubblico. In un Paese segnato da un forte calo delle nascite e da una popolazione sempre più anziana, con un carico crescente sulle famiglie, una sinergia tra politiche aziendali e politiche pubbliche potrebbe generare un circolo virtuoso di benessere sociale ed economico.
La formazione dei dipendenti è una forte leva di attraction e retention. Come Bauli dà risposta ai fabbisogni formativi dei propri dipendenti?
In Bauli, la formazione non è un elemento sostitutivo di elementi di remunerazione economica, ma un pilastro del nostro approccio allo sviluppo delle persone. È uno strumento essenziale che mettiamo a disposizione dei dipendenti per supportarli nella crescita professionale, al fine di mantenere la loro competitività e garantire un livello di preparazione adeguato in un contesto in continua evoluzione.
La formazione, però, non rappresenta di per sè sola un elemento di attraction o retention: è un elemento che fa parte di una visione più ampia e integrata del benessere delle persone in azienda. Per noi wellbeing significa anche creare un ambiente in cui ciascuno possa esprimere sé stesso, sentirsi accolto e valorizzato. Poniamo grande attenzione alle esigenze formative delle nostre persone. Abbiamo attivato diverse tipologie di Academy: una per profili più junior finalizzata all’accompagnamento in azienda attraverso percorsi strutturati di inserimento e crescita, favorendo la conoscenza delle diverse funzioni aziendali e un’integrazione efficace; ma abbiamo anche delle Academy dedicate a chi intraprende un percorso di sviluppo manageriale. Parallelamente, abbiamo investito molto nello sviluppo individuale, in un’ottica di promozione del self-development, anche attraverso strumenti digitali che consentano alle persone di agire in prima persona sul proprio percorso formativo, con riferimento sia ad esigenze specifiche (come la formazione linguistica), che rispetto alla messa a disposizione di contenuti molto più ampi (come LinkedIn Learning). Inoltre stiamo centralizzando tutte le opportunità su un unico Learning Management System (LMS) integrato nella nostra soluzione di Human Capital Management. La formazione, per noi, non è un premio, né un benefit. Deve rispondere a bisogni reali e concreti: che si tratti di corsi specialistici o di interventi “su misura” costruiti in base ai piani di crescita individuali, fino ad attività di coaching personalizzate. Cerchiamo di avviare continue nuove progettualità e ad esempio in questo senso, stiamo anche introducendo programmi di mentorship, che non sostituiscono altre iniziative, ma le integrano, con l’obiettivo di far crescere le persone nei loro ruoli, nel momento in cui scelgono di farlo. Le aziende oggi affrontano sfide importanti, a partire da quella della sostenibilità, e serve un impegno condiviso: percorsi di crescita e sviluppo vanno costruiti insieme, chiedendo alle persone partecipazione e responsabilità.
Bauli è da sempre un’azienda in cui le persone trovano naturalmente il proprio spazio. Anche nei periodi della cosiddetta great resignation, il nostro tasso di uscita è rimasto molto basso (intorno al 4%). Molti colleghi lavorano con noi da anni, inclusi numerosi stagionali che hanno trovato in Bauli una casa stabile. Storicamente legata a valori tradizionali – l’“azienda del Natale” per eccellenza – Bauli ha affrontato un importante processo di trasformazione per aprirsi all’esterno, attrarre nuove competenze e generare un ambiente più ricco di diversità culturale e professionale. Questo percorso di cambiamento ha avuto un impatto positivo e tangibile.
Abbiamo rivoluzionato il nostro modo di lavorare: da un’organizzazione molto rigida negli orari, siamo passati a una gestione flessibile, basata sulla fiducia. Abbiamo eliminato le timbrature per i white collar, introdotto lo smart working fino a 10 giorni al mese, adottato orari flessibili con recupero su base mensile, dando a ciascuno la possibilità di gestire in autonomia la propria giornata lavorativa. Questi cambiamenti – apparentemente piccoli – hanno trasformato profondamente il modo in cui le persone vivono l’azienda, in alcuni casi riuscendo ad attecchireanche su aree organizzativamente più difficli da gestire con simili strumenti, come quella delle Operations. Abbiamo scelto di raccontare questo cambiamento anche all’esterno, portando avanti uno stile più informale, anche nel dress code (che di fatto segue il principio della sola “appropriatezza”) e nella comunicazione interna ed esterna, rafforzando così il nostro employer branding. Tante nuove persone sono entrate in azienda in questo periodo, dando vita a un positivo crash culturale e generazionale che ha portato nuova energia e stimoli a tutta l’organizzazione.
Le competenze ricercate dalle aziende non sono più solo quelle tecniche, ma si sta ponendo sempre maggiore attenzione alle cosiddette soft skills: in cosa risiede, a suo avviso, il valore di questo tipo di competenze? Cosa si può fare concretamente valorizzare le soft skills?
Per noi è fondamentale ricercare profili che combinino competenze tecniche e attitudini comportamentali, strettamente legate al ruolo. Non amo la distinzione netta tra hard e soft skills: anzi, verrebbe quasi da ribaltare il concetto, perché in un contesto di continuo cambiamento culturale e generazionale, le competenze “trasversali” sono spesso quelle che fanno davvero la differenza.
Viviamo in un mondo che cambia rapidamente, e di conseguenza anche le organizzazioni devono cambiare. L’attitudine al cambiamento è una qualità chiave, che ricerchiamo con attenzione fin dal processo di selezione. Cerchiamo change agents: persone capaci di portare uno sguardo nuovo, di abbracciare e promuovere la cultura aziendale, contribuendo attivamente a trasformarla. Perché il cambiamento, per essere reale, ha bisogno di un certo grado di disruption – e soprattutto di energia, idee nuove e voglia di fare le cose in modo diverso rispetto al passato. Mi piace parlare di profilo attitudinale: non è una qualità che cerchiamo solo nei ruoli manageriali, ma anche nei neolaureati e negli stagisti, che spesso entrano in azienda con un forte potenziale e vengono poi confermati. In questo percorso di evoluzione abbiamo bisogno di contaminazione positiva: stiamo portando in azienda diversità di genere, di cultura, di esperienze e di generazioni. È proprio da questa ricchezza che nasce la crescita. In fondo, tenere giovane un’azienda con oltre 100 anni di storia significa anche questo: preservare una mentalità aperta, curiosa, con quella voglia di imparare che appartiene ai bambini.
La GenZ sta dimostrando un approccio nuovo rispetto al lavoro, è una tendenza che riscontrate anche in Bauli? Quali sono gli strumenti che possono essere implementati per favorire l’incontro tra i bisogni aziendali e quelli dei giovani?
Non amo le generalizzazioni, specialmente quando si parla della Gen Z. Dire che “sono tutti così” è eccessivamente riduttivo. È vero che alcuni tratti ricorrenti emergono, anche per il fatto che questa generazione è cresciuta in un periodo storico molto specifico. Valorizzano fortemente l’equilibrio tra vita e lavoro, un ambiente sano dove poter trovare il proprio spazio, e una visione aziendale che vada oltre il solo business, capace di incarnare valori e senso.
Tuttavia, anche all’interno della Gen Z esistono molte differenze, legate a percorsi personali, educazione, contesti culturali. Non possiamo appiattire tutto su un unico modello.
Questi nuovi valori, però, sfidano profondamente chi – come me – proviene da un’altra generazione. Ci mettono di fronte a un cambio di paradigma: ciò che una volta chiamavamo “etica del lavoro” oggi si esprime in modo diverso. Non è sparita, ma si è trasformata. Per molti giovani, il lavoro non rappresenta più un valore assoluto, ma uno dei tanti strumenti per realizzarsi, per dare spazio a ciò che davvero conta per loro.
Il nostro ruolo, come HR, non è correggere questa visione con frustrazione o nostalgia. Al contrario, dobbiamo rispettarla. Sarebbe una forzatura – quasi una violenza – cercare di cambiarla. Piuttosto, dobbiamo imparare a convivere con queste nuove prospettive, accoglierle, integrarle. Non si tratta di accontentare la Gen Z, ma di costruire contesti di lavoro più umani e inclusivi per tutti. Molti degli interventi che stiamo implementando – come la flessibilità oraria, lo smart working, l’attenzione al wellbeing – non sono pensati per la Gen Z, ma con una logica trasversale, perché ogni persona, a prescindere dall’età, ha esigenze diverse. È chiaro che, in un sistema culturale come il nostro, queste pratiche rappresentano anche una leva di attraction e retention per i più giovani, ma il loro valore è universale.
La sostenibilità, ad esempio, è un altro tema centrale. In Bauli redigiamo il bilancio di sostenibilità da prima che diventasse un obbligo normativo. Lo facciamo non per aderire a un trend, ma perché riteniamo sia una responsabilità reale in un mondo segnato dalla scarsità di risorse. Che questo diventi anche un elemento attrattivo per le nuove generazioni è un valore aggiunto, ma non l’obiettivo. Vogliamo creare un ambiente in cui ognuno possa essere se stesso. Un luogo che favorisca la contaminazione tra generazioni, esperienze e competenze. In quest’ottica, immaginiamo anche forme di reverse mentoring, dove i giovani possano aiutare a far crescere le competenze digitali e culturali delle persone più senior. La digitalizzazione fa parte del loro DNA, ed è giusto valorizzare questo vantaggio.
Vi racconto un piccolo aneddoto: circa due anni e mezzo fa, durante un incontro con un nostro partner, era presente anche una referente commerciale che all’epoca non aveva ancora trent’anni. Con noi c’era anche il CEO. Le chiese, in modo molto diretto: “Tu, per come hai conosciuto Bauli, ci verresti a lavorare?” Lei rispose con grande onestà: “Onestamente no. Mi sembra ancora un’azienda un po’ tradizionale, old style.” Ci siamo ritrovati con lei poco più di un anno dopo. Le abbiamo raccontato il percorso di cambiamento culturale, i nuovi approcci, le pratiche introdotte. E alla stessa domanda, lei rispose: “Adesso ci penserei davvero.”
È noto che esista un mismatch tra curricula e competenze professionali: quali modalità potrebbero essere ulteriormente sperimentate per favorire la collaborazione tra sistemi formativi e imprese nel colmare questo gap?
Il mismatch tra offerta formativa e fabbisogni delle imprese è una realtà che permane, e al momento non si intravedono soluzioni a breve termine. Questo divario si amplifica in un contesto dove il cambiamento delle competenze richieste è continuo, rapido e spesso difficile da anticipare.
I tirocini rappresentano per noi uno strumento prezioso, che utilizziamo in modo sistematico ma mai scontato. Accogliamo anche studenti delle scuole superiori, ma in questo caso si tratta spesso di una risposta a una richiesta. Diverso è il discorso per le collaborazioni strutturate: partecipiamo attivamente a career day e abbiamo rapporti consolidati con diverse istituzioni formative (Università, scuole secondarie superiori, istituti tecnici, ecc.). In particolare, riteniamo fondamentali gli strumenti di alternanza scuola-lavoro, come quelli offerti dagli ITS, che permettono di creare un ponte solido tra il percorso post-diploma e il mondo aziendale. Percorsi di questo tipo facilitano un’integrazione fluida tra teoria e pratica e andrebbero rafforzati anche nell’ambito universitario. L’università, infatti, dovrebbe aprirsi di più all’alternanza già durante il percorso di studi, non solo nel post-laurea.
Le aziende, dal canto loro, hanno una responsabilità importante e non possono limitarsi ad aspettare: una parte dell’onere formativo spetta a noi. In questo senso, stiamo valutando progettualità condivise con altre imprese del territorio tra cui un percorso congiunto con altre due importanti realtà del territorio, per formare profili professionali oggi particolarmente scarsi perché solo unendo le forze si possono costruire soluzioni sostenibili e replicabili. Non esiste comunque uno strumento unico che risolva il problema. La parola chiave è integrazione, e riguarda non solo l’inserimento dei giovani nelle aziende, ma anche l’apertura delle aziende verso il mondo della formazione. Questo approccio bidirezionale è strategico non solo per la preparazione dei futuri lavoratori, ma anche in chiave di employer branding e attraction: le aziende devono imparare a entrare nei luoghi della formazione per essere attrattive nel lungo periodo. Tuttavia, permane una certa rigidità nel sistema universitario. Spesso i tirocini obbligatori previsti dai piani di studio sono troppo brevi e scollegati da un reale percorso di apprendimento, con benefici minimi sia per l’azienda sia per lo studente. In un mese non si può conoscere davvero una persona né costruire un’esperienza formativa di valore e il placement resta ancora troppo concentrato sulla fase post-laurea, quando invece serve un’ibridazione più precoce tra studio e lavoro.
Le competenze, soprattutto quelle attitudinali, si imparano facendo e l’esperienza on the job rimane la leva più efficace per svilupparle. In questo scenario, strumenti diversi – come gli stage, le Academy, l’alternanza – devono coesistere con finalità differenti, ma complementari. Il tirocinio è utile come primo contatto e banco di prova, sia per il giovane, che può mettersi in gioco, sia per l’azienda, che può valutare potenziali inserimenti futuri. In questa logica, una remunerazione equa non è un optional, ma un tema di integrità.
Infine, quando ci si trova di fronte a una carenza concreta di competenze, è essenziale saper guardare al medio-lungo termine: formare una persona mentre è ancora in fase di apprendimento è una grande opportunità per entrambe le parti. Il lavoro si fonde con la formazione, e la crescita è reciproca, ma deve essere un rapporto corretto, trasparente e remunerato in modo adeguato.
PhD Candidate ADAPT – Università di Siena
Condividi su: